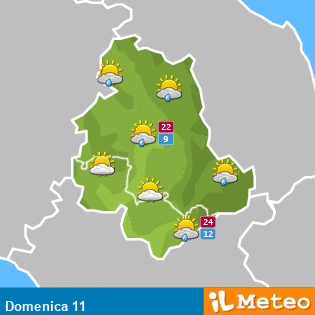a cura della Redazione di Perugia
Si conclude con trentasei ordinanze di custodia cautelare una delle più grandi operazioni antidroga degli ultimi tempi portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia di Perugia e messa a segno dagli uomini della squadra mobile diretti dal dirigente Marco Chiacchiera. Giovedì mattina interrogatorio di garanzia per gli arrestati – circa la metà – mentre gli altri sono ancora a piede libero.
Interrogatori di garanzia Dalle 10 alle 15: interrogatori fiume questa mattina nel carcere di Capanne per gli arrestati, difesi dagli avvocati Daniela Paccoi, Guida Maria Rondoni, Barbara Romoli, Donatella Panzarola e Cristian Giorni. E, inaspettatamente, molti di loro hanno scelto di non rimanere in silenzio, anzi hanno parlato, ammettendo in parte le loro colpe. Che però sarebbero state ‘superate dal tempo’: nella maggior parte dei casi si tratta di persone che hanno commesso i reati di cui vengono accusati negli anni addietro, per far fronte ad impellenti necessità di soldi, ma che – questa la loro versione – si sono poi integrati nella società e hanno trovato un lavoro che permette loro di vivere onestamente.
Istanza di scarcerazione Ecco perché, per molti di loro, i legali hanno chiesto o chiederanno l’annullamento della misura restrittiva: nella maggior parte dei casi – questa la tesi difensiva – gli arrestati hanno un lavoro, una famiglia e conducono una vita onesta e tranquilla. C’è chi fa il pasticciere, chi l’operaio, chi l’impiegato. I reati (eventualmente) commessi si riferiscono ad un periodo della loro vita precedente, ormai superato dagli eventi. E per questo, sempre secondo i legali, la custodia in carcere sarebbe esagerata e rischierebbe fra l’altro di avere conseguenze sulla vita degli indagati, che temono di perdere il proprio lavoro.
LE PAROLE DELL’AVVOCATO PACCOI (VIDEO)
Nelle carte, firmate dal gip Carla Giangamboni, emerge come ad operare ci fosse un vero e proprio sodalizio criminale composto da soggetti di etnia albanese, che acquistavano e vendevano cocaina, predisponendo mezzi, autovetture, telefoni cellulari non intestati agli indagati e predisponendo luoghi ben nascosti dove occultare lo stupefacente e le somme di denaro provento della relativa vendita. Attorno a loro, ruotavano tutta una serie di persone che avevano formato una fitta rete di acquirenti e clienti sul territorio, che mantenevano stabili collegamenti con i fornitori. A capo dell’organizzazione criminale Francesko Halili, detto ‘Kriza‘, «al vertice dell’organizzazione e la cui leadership viene riconosciuta da tutti i sodali», assieme al suo braccio destro Fatjon Cardaku, detto ‘Fabio‘, addetto a nascondere le partite di droga nonché il denaro. Era lui, secondo gli inquirenti, a organizzare appuntamenti, rifornire di autovetture il sodalizio.
Le indagini A far partire, nel 2013, l’operazione poi denominata ‘Big Rock’, è stata una cittadina peruviana che si è presentata direttamente in Questura, raccontando come in modo del tutto involontario, il suo compagno si fosse ritrovato suo malgrado coinvolto nell’importazione dal Sud America di un pacchetto di cocaina, nascosta dentro alcune paia di scarpe da bambino. Da lì in poi le indagini hanno portato a scoprire alcuni soggetti all’interno del sodalizio che, come scrive il Gip, erano soliti «nascondere lo stupefacente, anche in quantità ingenti, ed il denaro ricavato dagli illeciti traffici, in nascondigli ricavati in aperta campagna, sia pure a breve distanza dalle principali vie di transito». In questo modo, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, i trafficanti ne sarebbero usciti puliti, senza droga e soldi in tasca, mentre grazie alle intercettazioni ambientali e al sistema Gps installato sulle vetture in uso ai capi del sodalizio, è stato possibile recuperare vari chilogrammi di cocaina e più di 143 mila euro.
Le attività All’interno delle automobili, secondo quanto sono riuscite a carpire le cimici poste dalla polizia, i trafficanti parlavano in libertà mentre effettuavano gli spostamenti dalle campagne intorno al Trasimeno, dove nascondevano la droga, fino al luogo dove incontravano i clienti. L’organizzazione era molto attiva. «Io settimana scorsa non mi sono fermato un attimo – queste le parole trascritte nell’ordinanza dai dialoghi di uno degli indagati – tutti i giorni, per tutti i giorni che sono stato a lavoro, 40 di martedì, 40 di mercoledì, 35 di giovedì, 50 di venerdì, 50 di sabato, 30 ieri sera… entro ed esco dal bosco, entro ed esco…». Il riferimento è alle dosi vendute.
La pistola In cambio di 25 grammi di cocaina, nel 2014, il gruppo ottiene anche una pistola, una Beretta semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa. «È come un cannone – commentano i trafficanti dopo aver ritirato l’arma – anche se bisogna pulirla perché è piena di grasso». La ritroveranno nascosta tra gli arbusti gli inquirenti, dopo aver seguito la macchina di Halili e Cardaku, avvolta in un panno celeste con a fianco una confezione di cartone in cui erano nascoste cinquanta munizioni integre.
Le risse Nell’aprile del 2014, davanti a un centro commerciale di via Settevalli, il gruppo incontra una banda rivale composta sempre di cittadini di origine albanese e scoppia una rissa. Un paio di giorni dopo, fuori da un locale di Corciano, le due bande si scontrano di nuovo e proprio Halili viene accoltellato. Per evitare che dell’accaduto siano informati i carabinieri di Perugia, «Halili è infatti clandestino e già destinatario di decreto di espulsione», viene accompagnato all’ospedale di Arezzo e, fornendo false generalità, riferisce di essersi ferito con un pezzo di vetro mentre giocava a calcetto con degli amici. Al centro della rivalità tra le due bande la ‘sospetta scomparsa’ di una partita di droga e soldi, che manda su tutte le furie Halili. In realtà, la cocaina e il denaro, sono stati sequestrati nei boschi dalla polizia, ma il boss non lo sa e le sue intenzioni sono chiare: «Uno mi diceva: no, non lo sapevo, non sapevo che fosse tua….Non l’ho picchiato bene, perché temevo che morisse. Ho temuto che moriva proprio perché lo stavamo colpendo in testa».